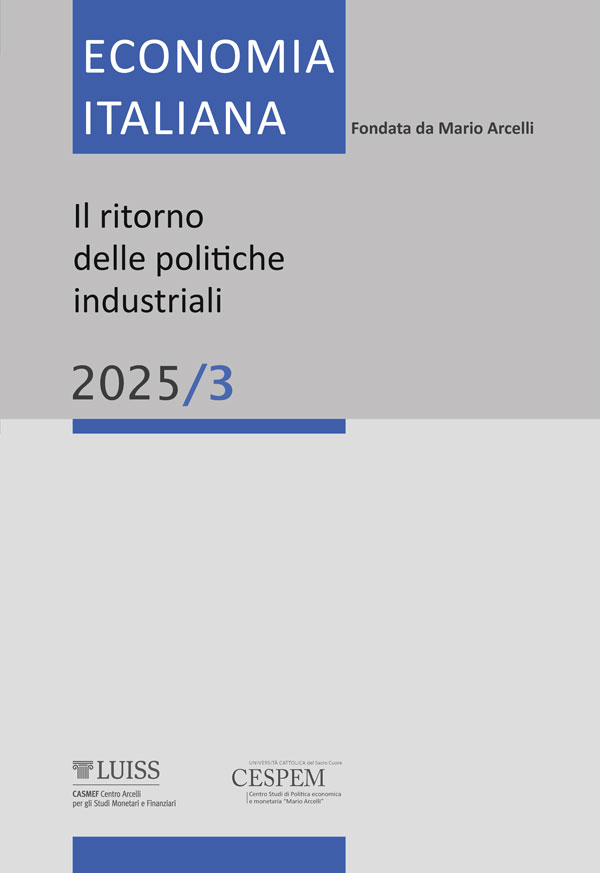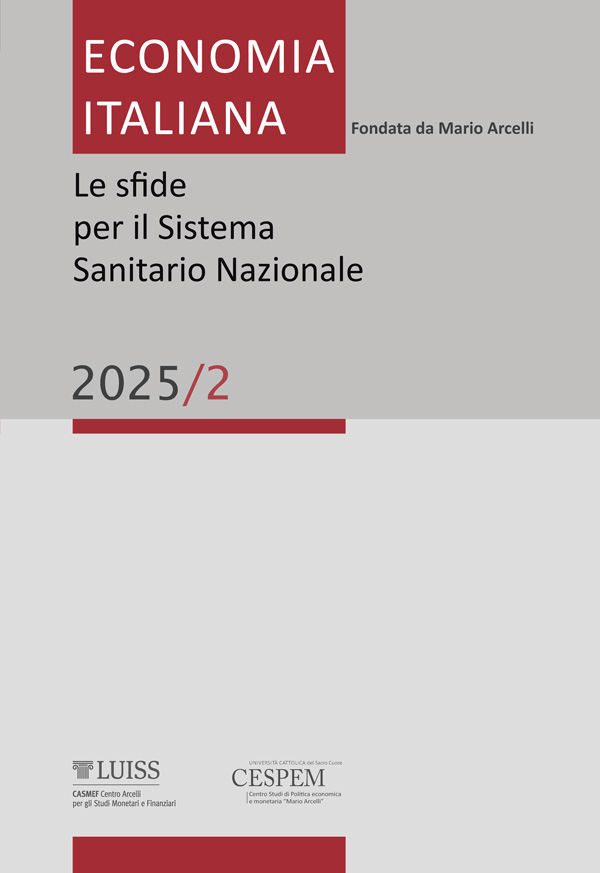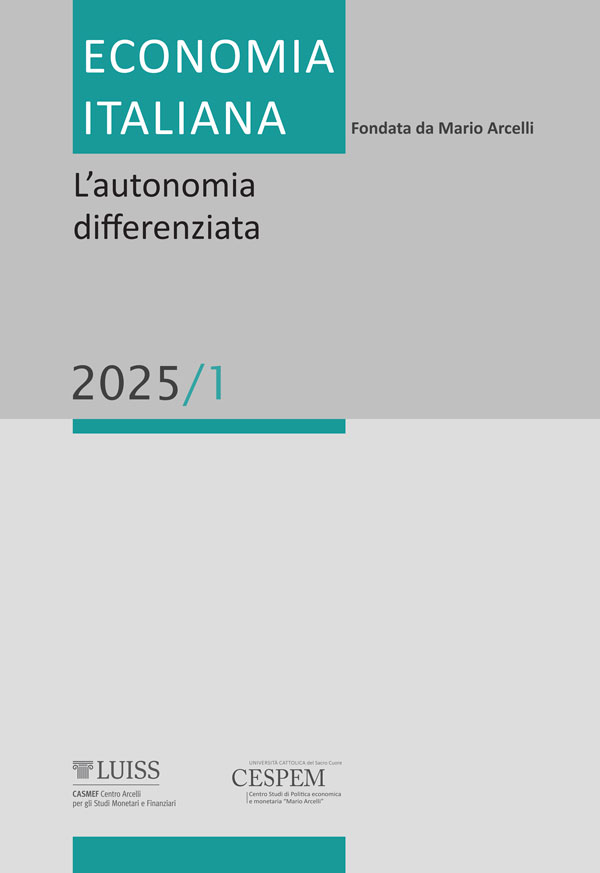Pubblicazioni
Numero
2025/03
Sintesi del numero
Il ritorno delle politiche industriali
L’intervento pubblico nelle cosiddette economie di mercato è stato considerato per lunghi anni con diffidenza per gli effetti negativi sulla concorrenza. Il nuovo contesto geo-politico e post Covid-19 impone di sviluppare un’offerta di beni pubblici molto più ampia.Fa il punto della situazione con riferimento all’Europa questo numero di EI, curato da Sergio De Nardis e Valentina Meliciani della Luiss.
Il modello macroeconomico europeo non dovrebbe essere più dipendente dal traino di un mondo insicuro ma trovare il nuovo motore nella domanda interna del continente e nel pieno sviluppo del suo mercato domestico. Transizione verde, tecnologie digitali, competitività, sicurezza economica e militare divengono quindi i molteplici fronti verso cui orientare il ritorno della politica industriale in Europa.
Le politiche industriali devono contribuire a innalzare la frontiera tecnologica europea, attraverso la promozione della digitalizzazione, per cercare di recuperare il gap di produttività con Usa e Cina. In questo schema, mercato unico dei capitali ed espansione della finanza per l’innovazione sono passi indispensabili per un percorso che potrebbe prospettarsi non breve e incerto negli esiti.
I contributi raccolti in questo volume, nel loro insieme, delineano un quadro organico della complessa posta in gioco. Fabrizio Onida ricostruisce la traiettoria storica della politica industriale europea tra l’attenzione alla salvaguardia della concorrenza e del mercato unico e l’esigenza di accrescere gli investimenti in innovazione e stimolare la produttività e sottolinea il ruolo strategico dei progetti tra pubblico e privato e degli IPCEI. Simone Vannuccini raccomanda di non cadere nella falsa dicotomia tra politica industriale e concorrenza, ma di disegnare una politica industriale pro-competitiva, fondata sulla produzione di beni pubblici europei — infrastrutture, standard, regolazione, capacità fiscale comune. Secondo Paolo Guerrieri e Pier Carlo Padoan, la politica industriale europea non può più essere letta solo in chiave economica, ma va integrata con le esigenze di sicurezza e con gli obiettivi della transizione verde e digitale. La domanda interna va rilanciata attraverso investimenti comuni, il pieno dispiegamento del mercato unico; cruciale è il tema delle risorse comuni. Anna Giunta e Marianna Mantuano si focalizzano sulla digitalizzazione delle imprese italiane. Tre i fattori critici individuati: polarizzazione crescente tra poche imprese digitalmente avanzate e un’ampia popolazione di piccole imprese confinate a tecnologie di base; insufficienti capacità manageriali per l’adozione delle tecnologie; politiche pubbliche instabili e proceduralmente complesse.
Come concludono gli editor, “il ritorno della politica industriale è l’esito obbligato di un mondo in cui sicurezza, sostenibilità e competitività tendono a sovrapporsi e a condizionarsi reciprocamente… una politica industriale europea efficace non deve mai rinunciare alla propria vocazione pro-concorrenziale, evitando derive protezionistiche e assicurando che gli interventi pubblici rafforzino e non indeboliscano la dinamica competitiva”.
Arricchiscono questo numero il contributo di Ignazio Visco, Un sostenibile “lungo periodo”? Sfide e prospettive per l’Italia di domani, che riflette sulle conseguenze di lungo periodo e sulla sostenibilità sociale ed economica delle tendenze in atto su tre fronti: tecnologia, ambiente e demografia. Seguono tre riflessioni sul sistema dei servizi di Carlo Sangalli, Alberto F. Pozzolo, Alberto Petrucci e una sul Tax Control Framework – Adempimento collaborativo di Riccardo Gabrielli e Lia G. Reitano.
Editor
Sergio De Nardis, Valentina Meliciani
Pagine
244 pagine
Articoli
Editoriale
Sergio De Nardis, Valentina Meliciani
Il ritorno delle politiche industriali
Saggi
Fabrizio Onida
Politica industriale europea ritorna
Simone Vannuccini
Autonomia strategica e politica industriale europea
Paolo Guerrieri, Pier Carlo Padoan
Rafforzamento della sicurezza economica europea, crescita sostenibile e politiche industriali. La triplice sfida dell’Europa
Anna Giunta, Marianna Mantuano
Transizione digitale: imprese e politica industriale
Ignazio Visco
Un sostenibile “lungo periodo”? Sfide e prospettive per l’Italia di domani
Rubriche
Carlo Sangalli
Il valore del sistema del turismo e dei servizi collegati
Alberto Petrucci
Sense of Italy: un vantaggio comparato per distinguere il Paese nei contesti competitivi globali
Alberto Franco Pozzolo
Sense of Italy: una lettura innovativa della struttura economica e culturale italiana
Riccardo Gabrielli, Lia Giusi Reitano
Tax Control Framework e Adempimento collaborativo: strumenti strategici per le imprese e per il sistema Paese
Elenco dei Referees
Elenco dei Referees
Indice dell'annata
Indice dell’annata
Numero
2025/02
Sintesi del numero
Le sfide per il Sistema Sanitario Nazionale
Questo numero, editor il prof. Vincenzo Atella (Università di Roma Tor Vergata), analizza le sfide cui si trova davanti il sistema sanitario italiano. Negli ultimi quattro decenni, i sistemi sanitari nazionali sono stati investiti da trasformazioni di portata storica che ne hanno profondamente modificato il ruolo, le funzioni e le modalità operative. Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano si trova in una fase critica, alle prese con l’impellente necessità di riformarsi in risposta alle sfide poste dal cambiamento, sinora trascurate: invecchiamento della popolazione, innovazione tecnologica, carenza di risorse, cambiamenti di paradigmi clinici ed organizzativi e disuguaglianze socioeconomiche.
Decenni di innovazione medica hanno cambiato rapidamente il panorama, ma il quadro organizzativo del SSN è rimasto indietro, con conseguenti inefficienze e disparità nell’assistenza. Per garantire un’assistenza sanitaria di alta qualità, equa e sostenibile per le generazioni future, gli autori sostengono che il SSN debba essere sottoposto a riforme complete. Questi cambiamenti dovrebbero allineare il finanziamento dell’assistenza sanitaria, l’erogazione dei servizi e la pianificazione del personale alle moderne capacità mediche e alle esigenze di salute della popolazione. È essenziale un approccio lungimirante, che riconosca l’evoluzione congiunta della politica sanitaria e della scienza medica e garantisca che l’adattamento istituzionale sia in linea con le realtà della medicina contemporanea. Affrontando queste sfide, il Servizio sanitario nazionale può trasformare i suoi meccanismi di erogazione dei servizi e mantenere il suo impegno a fornire un’assistenza sanitaria equa per tutti.
I saggi contenti nel numero affrontano svariate questioni. Nel primo saggio l’editor spiega le ragioni che rendono urgente una riforma del SSN: “The Urgent Need for an NHS Reform: Adapting to Overlooked Years of Transformation in Healthcare” (Atella). Si prosegue poi per temi: l’innovazione tecnologica, “Digital Disruption in Healthcare: What It Means for the NHS” (Atella e Chiari); il finanziamento della sanità pubblica (Atella, Cincotti, d’Angela, Polistena e Spandonaro); le disuguaglianze sanitarie “L’evoluzione delle disuguaglianze di salute in Italia (1984-2023)” (Atella, De Luca, d’Angela, Maresch, Polistena e Spandonaro); l’utilizzo dei dati sanitari e le regole della privacy, “Optimizing Population Health Through Strategic Use of Health Data” (Atella, Ganna, Lombardi); rafforzare la resilienza del sistema sanitario “The One Health (OH) Approach and the Sustainability of Healthcare Systems” (Atella e Scandizzo).
Editor
Vincenzo Atella
Pagine
490 pagine
Articoli
Editoriale
Vincenzo Atella
Le sfide per il Sistema Sanitario Nazionale. Guida alla lettura
Saggi
Vincenzo Atella
The Urgent Need for an NHS Reform: Adapting to Overlooked Years of Transformation in Healthcare
Vincenzo Atella, Lorenzo Chiari
Digital Disruption in Healthcare: What It Means for the NHS
Vincenzo Atella, Felice Cincotti, Daniela d’Angela, Barbara Polistena, Federico Spandonaro
Finanziamento e Spesa Sanitaria in Italia
Vincenzo Atella, Cecilia De Luca, Daniela d’Angela, Emily Maresch, Barbara Polistena, Federico Spandonaro
L’evoluzione delle disuguaglianze di salute in Italia (1984-2023)
Vincenzo Atella, Andrea Ganna, Stefano Lombardi
Optimizing Population Health Through Strategic Use of Health Data
Vincenzo Atella, Pasquale Lucio Scandizzo
The One Health (OH) Approach and the Sustainability of Healthcare Systems
Recensioni
Massimiliano Parco
Pippo Ranci (a cura di), Economia dell’energia. Transizione ecologica e sostenibilità
Filippo Cucuccio
Mariano Bella (a cura di) Sense of Italy – Esportazioni, servizi, turismo, prosperità
Numero
2025/01
Sintesi del numero
L’autonomia differenziata
Questo numero di Economia Italiana – guest editors Massimo BordignoneGilberto Turati (Università Cattolica) eLeonzio Rizzo (Università di Ferrata) – è dedicato ai temi della “autonomia differenziata”, o del federalismo asimmetrico. Alla possibilità, cioè, che alcune funzioni attualmente svolte dallo Stato nazionale siano decentrate e attribuite ad (alcune) regioni assieme alle risorse per poterle svolgerle.
I lavori contenuti in questo volume contribuiscono al dibattito affrontando il tema da punti di vista differenziati. Si discutono gli aspetti normatividel decentramento alla luce anche della recente sentenza della Corte costituzionale, le caratteristiche dell’offerta dei principali servizi pubblici sul territorio, le possibilità che in specifiche singole materie maggior o minore decentramento possa condurre a maggior efficienza, si riflette criticamente su alcune esperienze di decentramento, si discute se e come la definizione dei livelli essenziali di prestazioni (LEP), anche indipendentemente dal decentramento, possano migliorare l’offerta dei servizi pubblici sul territorio. Gli autori sono (nell’ordine espositivo) M. Massa, G. Messina e R. Torrini, C.C. Losito e F. Porcelli, A. Zanardi, V. Carrieri, L.R. Pench, A. Baglioni, U. Galmarini e R. Secomandi. Il volume si chiude con due commenti, uno favorevole (G. Cerea), l’altro contrario (G. Pisauro), ai percorsi verso il federalismo differenziato, sia in termini generali che al modo con cui esso è stato perseguito in Italia negli ultimi anni.
Nel saggio introduttivo ai contenuti del volume, i curatori, dopo aver presentato e commentato i singoli saggi, lasciano al lettore la valutazione finale. Ci sono però alcuni aspetti che emergono dalla discussione che vengono sottolineati: la sentenza della Corte costituzionale ha (giustamente) molto circoscritto gli spazi possibili per l’autonomia differenziata; le richieste di decentramento devono essere giustificate, tenendo conto che l’attuale distribuzione della spesa del settore pubblico sul territorio non riflette né aspetti di efficienza né di equità; i LEP possono giocare un ruolo importante nel migliorare l’allocazione dell’intervento pubblico sul territorio, anche indipendentemente dall’autonomia differenziata, ma devono essere ben definiti e soprattutto attuati da parte del settore pubblico. Infine, il dibattito può essere l’occasione per rivedere alcune bizzarre conclusioni del regionalismo italiano, quale la convinzione che il federalismo fiscale si faccia con le compartecipazioni o che il governo non possa usare trasferimenti vincolati agli enti locali per sostenere politiche nazionali.
Editor
Massimo Bordignon, Leonzio Rizzo, Gilberto Turati
Pagine
338 pagine
Articoli
Editoriale
Massimo Bordignon, Leonzio Rizzo, Gilberto Turati
Il percorso accidentato dell’autonomia differenziata
Saggi
Michele Massa
Sotto la spada di Damocle. Problemi costituzionali e applicativi del regionalismo differenziato in Italia
Giovanna Messina, Roberto Torrini
La dimensione territoriale dell’offerta di servizi pubblici in Italia: una fotografia dell’esistente
Cesaria Claudia Losito, Francesco Porcelli
I Livelli Essenziali delle Prestazioni: identificazione e finanziamento alla luce dei lavori per l’attuazione dell’autonomia differenziata
Alberto Zanardi
La scuola nell’autonomia differenziata
Vincenzo Carrieri
Verso l’autonomia differenziata: riflessioni su devoluzione e sanità in Italia
Interventi
Lucio R. Pench
Autorità subnazionali e governance dell’UE: un rapporto problematico
Angelo Baglioni
Banche locali: quale spazio per la legislazione concorrente Stato-Regione?
Umberto Galmarini, Riccardo Secomandi
La finanza locale decentrata nelle Regioni e Province autonome del Nord Italia
Gianfranco Cerea
Stato, regioni e territori. L’autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte Costituzionale
Giuseppe Pisauro
Perché no a questa autonomia differenziata