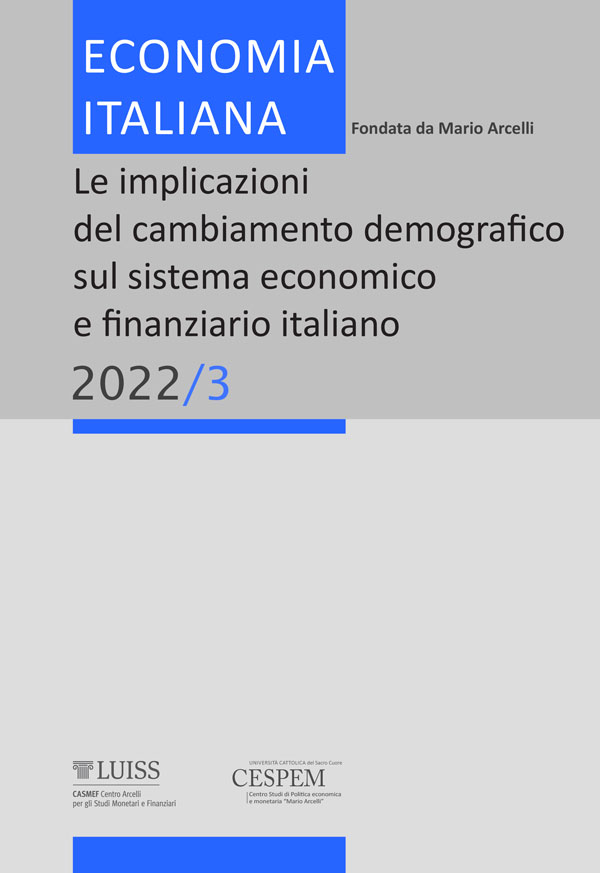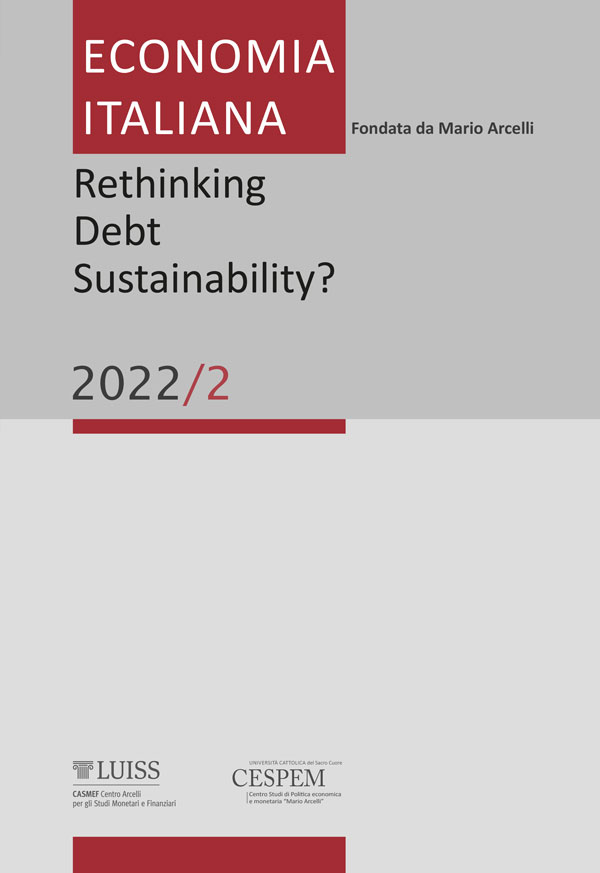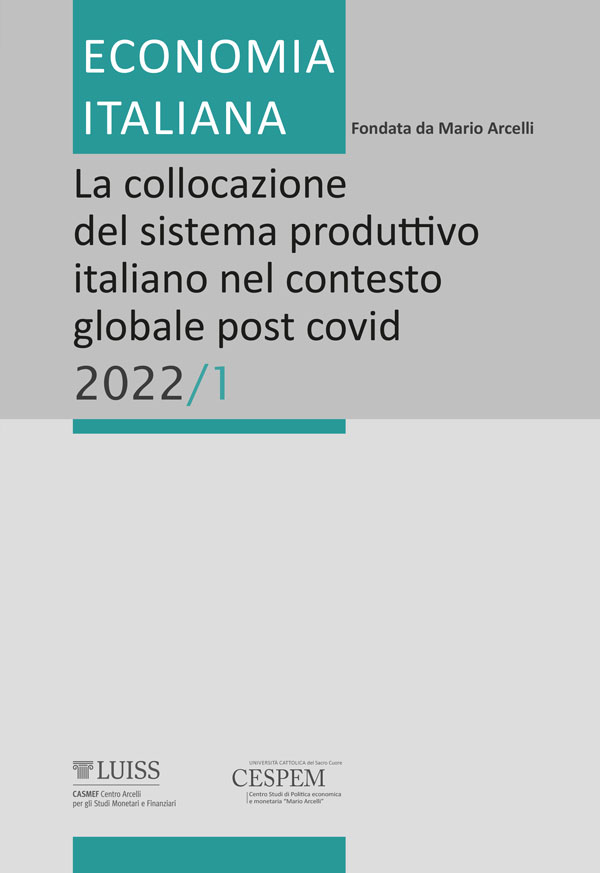Pubblicazioni
Numero
2022/03
Sintesi del numero
Le implicazioni del cambiamento demografico sul sistema economico e finanziario italiano
Questa edizione di Economia Italiana – editor Giorgio Di Giorgio e Maria Rita Testa, entrambi della Luiss – analizza le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione in Italia. Come scrivono gli editor, “L’Italia non è un paese per giovani”. Negli anni a venire gli anziani sono destinati a diventare più di un terzo della popolazione, mentre i giovani dovrebbero ridursi a poco più di un decimo rispetto a una popolazione che – nel prossimo cinquantennio a seconda di diversi autorevoli scenari centrali previsi – perderà dai cinque ai diciassette milioni di individui. “L’impatto sulla società sarà dirompente non solo per il cambiamento atteso futuro ma anche perché ad oggi le avvenute trasformazioni demografiche si sono scontrate con ben pochi risultati concreti e molto silenzio da parte delle istituzioni preposte a rispondere a siffatto cambiamento”.
Il primo contributo, di Claudia Reiter, Anne Goujon e Maria Rita Testa, mette in evidenza le future tendenze demografiche italiane: Italy’s population prospects: future scenarios for the 21st century. Il saggio di Lilia Cavallari, Flavio Padrini, Nicola Salerno e Lorenzo Toffoli analizza l’impatto del potenziale aumento della spesa per le cure e per il welfare nel nostro paese, Ageing and the sustainability of public finance. Due contributi sono dedicati esplicitamente al tema delle pensioni. Carlo Lallo e Sergio Ginebri trattanoGli effetti regressivi inattesi del sistema pensionistico italiano nel prossimo futuro. Il lavoro di Elisa Bocchialini e Beatrice Ronchini si occupa delle forti disparità di genere nei trattamenti pensionistici italiani, Il gender gap pensionistico: evidenze e prospettive dalla previdenza complementare.
Il volume si chiude con il saggio di Domenico Curcio, Giorgio Di Giorgio e Giuseppe Zito, Scenari demografici, risparmio e sistema finanziario italiano, checontiene anche una proposta per sostenere le pensioni di chi non ha possibilità di versare adeguati contributi.
Completano il volume l’intervento di Stefano Micossi, Le questioni di politica economica sempre rinviate” e la rubrica di Marco Valerio Morelli, Il sistema pensionistico italiano appare non sostenibile nella società “silver” di domani.
Editor
Giorgio Di Giorgio, Maria Rita Testa
Pagine
256 pagine
Articoli
Editoriale
Giorgio Di Giorgio, Maria Rita Testa
La demografia in Italia e le scelte che contano
Saggi
Claudia Reiter, Anne Goujon, Maria Rita Testa
Italy’s population prospects: future scenarios for the 21st century
Lilia Cavallari, Flavio Padrini, Nicola Carmine Salerno, Lorenzo Toffoli
Ageing and the sustainability of public finance
Sergio Ginebri, Carlo Lallo
Gli effetti regressivi inattesi del sistema pensionistico italiano nel prossimo futuro
Elisa Bocchialini, Beatrice Ronchini
Il gender gap pensionistico: evidenze e prospettive dalla previdenza complementare
Domenico Curcio, Giorgio Di Giorgio, Giuseppe Zito
Scenari demografici, risparmio e sistema finanziario italiano
Interventi
Stefano Micossi
Le questioni di politica economica sempre rinviate
Rubriche
Marco Valerio Morelli
Il sistema pensionistico italiano appare non sostenibile nella società silver di domani
Numero
2022/02
Sintesi del numero
Rethinking Debt Sustainability?
This issue of Economia Italiana – editors Lorenzo Codogno, LSE, and Pietro Reichlin, Luiss – deals with public debt sustainability and fiscal rules. Many beliefs about the benefits of current fiscal and monetary policies could change because of the risks associated with the energy crisis, the war in Ukraine, the return of inflation and the green transition. The volume contains several contributions by leading experts on the following questions: Is debt sustainability a cause of concern within the Euro Area? How should we consider revising the Stability and Growth Pact in the European Union? Are the energy transition and the pandemic risks good reasons to build up EU-level fiscal capacity? In the introduction to this monograph, we will touch upon some of these issues and discuss why they are important.
Ripensare la sostenibilità del debito?
Questo numero di Economia Italiana – editor Lorenzo Codogno, LSE, e Pietro Reichlin, Luiss – tratta della sostenibilità del debito pubblico e delle regole fiscali. Molte convinzioni sui benefici delle attuali politiche fiscali e monetarie potrebbero cambiare a causa dei rischi associati alla crisi energetica, alla guerra in Ucraina, al ritorno dell’inflazione e alla transizione verde. Il volume contiene diversi contributi dei maggiori esperti sulle seguenti questioni: La sostenibilità del debito è fonte di preoccupazione nell’area dell’euro? Come dovremmo considerare la revisione del Patto di stabilità e crescita nell’Unione europea? La transizione energetica e i rischi di pandemia sono buone ragioni per costruire una capacità fiscale a livello europeo? Nell’introduzione di questa monografia, gli editor trattano alcuni di questi temi e spiegano perché sono importanti.
Essays by/Saggi di: Lorenzo Codogno, and Pietro Reichlin; Carmine Di Noia; Ludger Schuknecht; William R. Cline; Lorenzo Codogno, and Giancarlo Corsetti; Martin Larch; Cecilia Gabriellini, Gianluigi Nocella, and Flavio Padrini; Marzia Romanelli, Pietro Tommasino, and Emilio Vadalà; Angelo Baglioni, and Massimo Bordignon; Paul Van den Noord.
Editor
Lorenzo Codogno, Pietro Reichlin
Pagine
348 pagine
Articoli
Editoriale
Lorenzo Codogno, Pietro Reichlin
Rethinking Debt Sustainability?
Saggi
Carmine Di Noia
Sovereign debt in times of crises
Ludger Schuknecht
A new look at public debt sustainability
William R. Cline
Debt sustainability in emerging market economies after the Covid-19 shock
Lorenzo Codogno, Giancarlo Corsetti
Debt sustainability analysis is back. Sudden shifts in underlying factors may push high-debt countries into a bad equilibrium
Martin Larch
The (un)sustainability of public debt: the elusive reality of an intuitive concept
Cecilia Gabbriellini, Gianluigi Nocella, Flavio Padrini
A post-Covid-scenario analysis of Italy’s public debt ratio dynamics
Marzia Romanelli, Pietro Tommasino, Emilio Vadalà
The future of European fiscal governance: a comprehensive approach
Angelo Baglioni, Massimo Bordignon
Public debt sustainability, fiscal rules and monetary policy
Paul van den Noord
Reconciling fiscal and environmental sustainability in the Eurozone
Rubriche
Mariano Bella, Luciano Mauro
Appunti sulla stagflazione
Fabrizio Guelpa
Come una grande banca può aiutare le medie imprese esportatrici a fare il salto dimensionale
Numero
2022/01
Sintesi del numero
La collocazione del sistema produttivo italiano nel contesto globale post covid
Questo numero di Economia Italiana – editor i professori Giorgia Giovannetti, Università di Firenze, e Paolo Guerrieri, Sapienza e PSIA SciencesPO – fa il punto sul processo di globalizzazione e sulla relativa posizione dell’industria italiana. Nel 2021 commercio e investimenti internazionali hanno registrato tassi di espansione superiori alla media degli ultimi anni. Non si è verificata la fine della globalizzazione e un ritorno al protezionismo, prevista da molti. “Anzi – secondo gli editor – le catene del valore sembrano aver funzionato più come ammortizzatori e strumenti di risposta alla crisi che come amplificatori della stessa, anche se non vanno trascurati i problemi e le strozzature …e in effetti “L’internazionalizzazione è un canale importante per accrescere la produttività e la competitività ed è un fattore di crescita”.
L’Italia ha reagito meglio di altri paesi e sembra aver “difeso la propria posizione” nell’economia mondiale. La reazione migliore rispetto alla pandemia sembra esser stata quella delle imprese internazionalizzate – e in particolare di quelle partecipanti alle catene del valore – che hanno reagito meglio delle imprese domestiche in termini di minori perdite di fatturato, maggior usi di tecnologie digitali, e-commerce, etc.
Dai vari saggi contenuti nel fascicolo emerge con chiarezza il ruolo propulsivo delle grandi imprese italiane capaci di competere sui mercati. Tuttavia, queste non hanno un peso sufficiente a trainare il resto dell’apparato produttivo italiano. Da qui due implicazioni di policy: “il ruolo delle imprese medio-grandi è e deve restare assai importante, sia quali attori in grado di competere nelle grandi catene del valore internazionali, sia quali potenziali locomotive dell’espansione del sistema produttivo”; dall’altro “è altrettanto importante favorire maggiori dimensioni e managerialità del folto gruppo di piccole e piccolissime imprese che tendono a frenare in molti casi la capacità di integrazione internazionale del nostro sistema produttivo”.
Il volume contiene i saggi di Roberto Monducci e Stefano Costa (rilevanza crescente delle imprese medio-grandi e multinazionali nei flussi di esportazione italiani). Stefano Costa, Federico Sallusti, Claudio Vicarelli e Davide Zurlo (l’internazionalizzazione per accrescere competitività e performance del sistema produttivo italiano). Claudio Battiati, Cecilia Jona-Lasinio, Enrico Marvasi e Silvia Sopranzetti (la concentrazione del potere di mercato potrebbe migliorare l’efficienza senza compromettere la concorrenza). Luca Casolaro, Silvia Del Prete e Giulio Papini (l’impatto dell’internazionalizzazione nel caso della Toscana). Completano il numero gli interventi di Pierfrancesco Latini e Alessandro Terzulli (il futuro possibile delle catene globali del valore) e di Mariano Bella e Luciano Mauro (le ricadute effettive della bolletta energetica).
Editor
Giorgia Giovannetti, Paolo Guerrieri
Pagine
276 pagine
Articoli
Editoriale
Giorgia Giovannetti, Paolo Guerrieri
La collocazione del sistema produttivo italiano nel contesto globale post covid
Saggi
Stefano Costa, Roberto Monducci
Multinational enterprises in Italian foreign trade: growth strategies and resilience to the Covid-19 crisis
Stefano Costa, Federico Sallusti, Claudio Vicarelli, Davide Zurlo
Measuring Italian firms’ reaction to Big3s business cycle: a granular approach
Claudio Battiati, Cecilia Jona-Lasinio, Enrico Marvasi, Silvia Sopranzetti
Markups, productivity and Global Value Chains in the European economies
Luca Casolaro, Silvia Del Prete, Giulio Papini
Propensione a investire e apertura internazionale: il caso della Toscana
Rubriche
Pierfrancesco Latini, Alessandro Terzulli
Catene globali del valore: quale futuro possibile
Mariano Bella, Luciano Mauro
Per evitare ambiguità nei conteggi dei maggiori costi dell’energia
Recensioni
Giovanni Parrillo
E. Occorsio e S. Scarpetta, Un mondo diviso. Come l’Occidente ha perso crescita e coesione sociale. Con una prefazione di I. Visco.